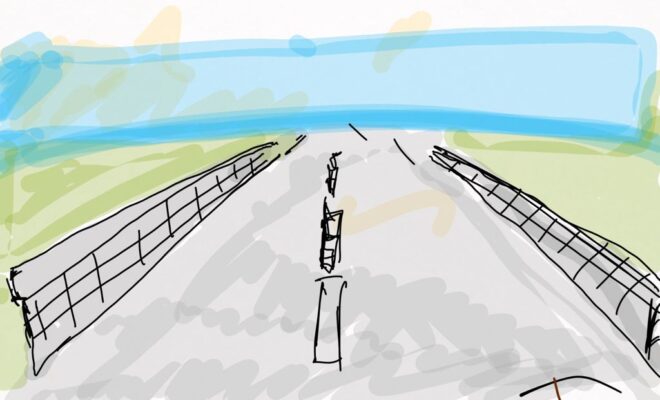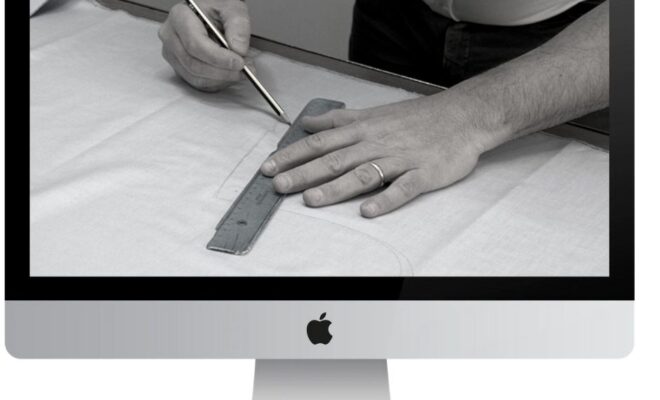La Blu Economy

La “Blu Economy” è una branca della green economy, che si pone come obiettivo fondamentale la totale eliminazione delle emissioni di CO2. È quindi un approccio ben più radicale rispetto alla green economy, che si prefigge un modello di business basato su un minor impatto ambientale, che riduca tali emissioni. La Blu Economy si basa sopratutto sull’innovazione e su metodi che possano creare uno sviluppo sostenibile proteggendo le risorse naturali e ambientali per le future generazioni. Il primo a parlare di Blu Economy è stato Gunter Pauli, economista belga e imprenditore di successo in numerosi settori. Pauli è il fondatore della Zero Emissions Research Iniziative (http://www.zeri.org/), una comunità internazionale della quale fanno parte studiosi, esperti in economia, scienziati e ricercatori per trovare insieme soluzioni efficaci rispetto ad una economia che tenga conto della tutela dell’ambiente e della persona in primo luogo.
La concentrazione di C02 nell’atmosfera a maggio 2019 era di 414,28 ppm (parti per milione), di poco inferiore al record toccato nel giugno 2018, quando era arrivata a 411,58 ppm, un valore mai raggiunto prima, il più alto da 800 mila anni. La Green Economy ha il proprio “deficit strutturale” nel fatto che rappresenta tutto ciò che è ottimale per l’uomo e la natura ma è purtroppo costosa, ovvero produce metodologie adatte solo alle popolazioni più ricche e pertanto insostenibili. La Blu, di contro è la strategia più adatta per gli scenari di povertà che purtroppo rappresentano i territori più vasti al mondo. Pertanto essa ha una potenzialità ben più vasta e globale: la chiave è quella di generare valore con tutte le occasioni e le risorse disponibili e di sviluppare economie piccole che generano valore a pioggia, con processi che sono legati in modo che questa concatenazione riduca i costi e crei benefici multipli.
Un esempio concreto: ogni volta che beviamo un caffè espresso, il suo residuo si può utilizzare per produrre mobili, come fertilizzante e anche per la coltivazione dei funghi. Per quest’ultimo impiego, il residuo è a sua volta un ottimo mangime per polli che deporranno le uova. Così anziché un solo flusso di cassa se ne hanno quattro e anche più e la realizzazione degli oggetti diventa meno costosa. Tale modello, sarebbe da applicare anche ai mari di tutto il mondo. In questo caso, il modello della Blu economy spinge alla lotta alla plastica e a lavorare alacremente sulla pulizia dei mari per salvaguardare un’ecosistema che rappresenta la settima potenza economica mondiale. Proteggere la salute degli ecosistemi marini è anche un’occasione di business. Basta un semplice dato per averne conferma: se gli oceani fossero uno stato, il loro prodotto interno lordo, tremila miliardi di dollari sarebbe superiore a quello di paesi come l’India e l’Italia e li renderebbe la settima economia al mondo in termini di ricchezza generata.
Un’economia che però è sempre più a rischio, a causa delle minacce ambientali – inquinamento, sovrasfruttamento delle risorse, riscaldamento globale – e delle pressioni dirette e indirette prodotte sui mari dalle attività produttive, che rischiano di compromettere definitivamente o quasi le possibilità di creare valore economico e sociale negli ambienti costieri e marini. Per arginare tali rischi, generando al contempo nuove opportunità imprenditoriali, la strada obbligata da percorrere è quella della sostenibilità: a dirlo è il primo rapporto Business for Ocean Sustainability, presentato a Milano lo scorso 5 novembre e realizzato da One Ocean Foundation, organizzazione dedicata alla salvaguardia dei mari nata da un’idea dello Yacht Club Costa Smeralda (Yccs). Scopo principale di tale rapporto, realizzato in collaborazione con la School of Management dell’Università Bocconi, la società di consulenza McKinsey e il Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo (Csic), è dare alle imprese delle linee guida realistiche ed illustrare le pratiche virtuose già messe in campo da alcune di esse sul versante della tutela dell’ambiente marino.
Esso ha analizzato quali sono i settori industriali che esercitano le maggiori pressioni ambientali dirette ed indirette sugli oceani, basandosi sui dati di istituzioni ed enti di ricerca e tenendo conto degli 11 indicatori di salute ambientale (Ges) definiti dall’Unione europea. Il secondo step, è stato quello di somministrare alle aziende dei questionari per accertare il loro grado di consapevolezza dell’impatto della loro attività sugli oceani e quali fossero le iniziative da loro promosse per mitigarlo. Secondo i dati raccolti e analizzati, le imprese coscienti della pressione sugli ecosistemi marini del proprio settore industriale sono il 35 per cento e, per la maggior parte, si sforzano di ridurre questo impatto. Le criticità più note alle aziende sono quelle promosse da movimenti di opinione, ad esempio riguardo l’inquinamento da plastiche e microplastiche, mentre più limitata è la conoscenza delle pressioni indirette come lo sfruttamento eccessivo delle risorse marine. Se le aziende sia consapevoli che attive (i leader della sostenibilità) sono il 34%, c’è però ancora molta strada da fare: il 44% infatti è non consapevole né attiva (ritardatari) e il restante 22% si divide tra consapevole ma inattiva (bloccati) e inconsapevole ma attiva (interessati).